Il rapporto di sintesi NDC della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dello scorso 26 febbraio afferma che il prossimo decennio, 2020-2030, sarà cruciale per il futuro dell’umanità. In attesa della COP26 di Glasgow nel novembre 2021 sono stati infatti registrati gli obiettivi di stabilizzazione dell’aumento della temperatura media globale cui ciascun Stato avrebbe dovuto contribuire “pro quota” per non oltrepassare il limite di 1,5°C. L’accordo di Parigi del 2015, infatti, lascia nelle mani degli Stati/Parti la decisione sulle riduzioni delle emissioni da effettuare per raggiungere l’obiettivo sopra menzionato e che si quantificano nei cosiddetti “Contributi Determinati a livello Nazionale” (NDC) da confermare ogni cinque anni.
Con estrema preoccupazione, si è rilevato che – stanti gli esigui livelli stimati di riduzione di CHG tra il 2015 e il 2020, la previsione di riduzione da qui al 2030 dovrà essere di ben 55 GtCO2eq. Entro la fine del 2020, erano stati aggiornati solo 48 NDC, che rappresentano 75 Stati/Parti responsabili di circa il 30% delle emissioni globali di gas serra. Su questo primo rilevamento la riduzione delle emissioni rispetto al 2015 è risultata di un misero 2,8%.
La situazione è estremamente scoraggiante e l’Italia con il suo attuale piano energetico rientra in queste sconsolanti dimensioni, puntando anch’essa furbescamente alla cosiddetta “neutralità del carbonio” a metà del secolo, piuttosto che intraprendere un’ambiziosa mitigazione già nel prossimo decennio. Senza raggiungere gli obbiettivi posti dal Green New Deal europeo, saremmo tra i responsabili della esposizione della totalità degli ecosistemi del pianeta a condizioni mai registrate durante il periodo geologico in cui la nostra specie si è sviluppata.
Di ciò si rende conto anche Federico Fubini che, nell’articolo del Corriere della Sera del 10 maggio, si chiede se ci sia piena coscienza della sfida cui siamo tenuti e della profondità delle trasformazioni che ci attendono con l’abbandono dei fossili.
Trovo molto appropriata la sua riflessione sulla “distrazione” degli italiani al riguardo ma continua a sorprendermi come praticamente tutto il mondo dell’economia e della politica non riesca a liberarsi di un assioma: qualunque trasformazione produttiva e degli stili di vita diventi necessaria, non può contare su una diminuzione del Pil, destinato immancabilmente a crescere per garantire occupazione, ripresa ed esorcizzare ogni emergenza futura. Inoltre – altro assioma – il mantenimento dello stile di vita in corso va preservato.
Va da sé che le potenze ed i consumi energetici continuerebbero a espandersi: “Come potremmo – argomenta il giornalista – azzerare i settemila chili di carbonio che ogni italiano emette nell’atmosfera ogni anno? Solo e soltanto con 70 GWatt di energie rinnovabili, equivalenti ad una cinquantina di centrali nucleari come quelle francesi, tappezzando di pannelli solari oltre 200 mila ettari, quasi il 2% della superficie coltivata in Italia e piantando pale eoliche letteralmente ovunque, compromettendo un paesaggio secolare e la risorsa del turismo?”. E’ chiaro l’avvertimento: riconosco che il tempo per evitare la catastrofe stia venendo a mancare, ma “perché allora rinunciare al sequestro del carbonio o all’idrogeno prodotto anche da gas naturale, per non parlare di una dose di nucleare nel mix complessivo?”.
I numeri forniti nell’articolo del Corriere sono un tantino esagerati anche a parità di consumo (oggi si può avere 1,5 MW per ettaro da fotovoltaico e la prospettiva di pale eoliche da oltre 4 MW si colloca off-shore, fuori cioè dalla vista da riva), ma nemmeno troppo se il sistema rimane inalterato. Oltretutto, si sottovaluta che si tratta di fonti di energia funzionanti senza emissioni climalteranti, in continua evoluzione e specificatamente decentrate, oltre che pianificabili con accumuli che ne migliorano il rendimento discontinuo. Già questo basterebbe a farne d’obbligo la tecnologia sostitutiva dei fossili. Ma non basta: occorre puntare alla sufficienza elettrica e riorganizzare una struttura ottimizzata per fonti diffuse e con un risparmio netto a parità di benefici resi.
Non c’è invece alcuna soluzione consolatoria se si continua a consumare e produrre come abbiamo imparato dal sistema centralizzato del carbone, del petrolio e del gas, sprecando nella combustione, ostacolando la creazione e la condivisione comunitaria dei sistemi energetici, organizzando una mobilità fatta di veicoli proprietari che stanno in coda, programmando cicli di vita che accelerano la trasformazione di prodotti in scarti e facendo degli allevamenti intensivi e dell’agricoltura una sorgente di inquinanti e, infine, illudendoci che il ricorso al metano non ci riservasse la minaccia più grande a breve per il riscaldamento del pianeta.
Trovo certamente di rilievo che un giornalista come Fubini ci spinga a riflettere su un futuro prossimo in cui le scelte si rifletteranno immediatamente sugli stessi stili di vita e sul nostro rapporto con la natura, il paesaggio, l’intero vivente. Ma non c’è continuità praticabile, se si persegue davvero l’equilibrio climatico ed una maggiore giustizia sociale. Molte e incalzanti sono le novità con cui misurarsi e a cui ci sottopone una scienza sempre più allarmata della sopravvivenza. A questo punto, vorrei fare riferimento ad un recentissimo studio patrocinato dall’UNEP che rivela che, se l’anidride carbonica ha un ruolo fondamentale nel riscaldamento globale, nondimeno il metano (CH4), con un potenziale di riscaldamento molto più alto della CO2 (di ben 28 volte considerando un orizzonte temporale di 100 anni), merita altrettanta attenzione. Anzi, nel breve periodo (i primi venti anni) ancora maggiore attenzione, se si vuole stare nei limiti di temperatura di 1,5°C. Ogni giorno di più ci accorgiamo che la sindemia è un avvertimento per un cambio di passo irreversibile. Proprio questo cambio accelerato andrebbe favorito dai fondi Next Generation.
Per andare a casi concreti, penso, ad esempio, all’insistenza di Enel sull’impiego del metano nella centrale di Civitavecchia, dove le articolazioni istituzionali, civili, sindacali – perfino religiose – hanno provato a far lievitare dal basso un modello di fornitura e consumo elettrici non più incatenati ai fossili, per ritrovarsi poi, nelle tabelle del PNRR, poste di bilancio deludenti, che confermano i fumi da combustione che hanno afflitto da oltre settant’anni la città e il litorale laziale e con accenni solo irrisori all’eolico off-shore, o all’accumulo in pompaggi o idrogeno verde, che aprirebbero spazi occupazionali, con una specializzazione manifatturiera ed una logistica portuale di pregio in un territorio che per il suo futuro ha scelto il passaggio desiderabile all’energia del sole, del vento, dell’acqua.
L’articolo Rinnovabili, l’impatto della transizione è troppo caro? Cambiare consumi e stili di vita è cruciale proviene da Il Fatto Quotidiano.

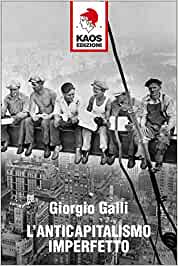 Galli rileva una continuità col passato che non sembra incontrare ostacoli, anche perché, se i rapporti e i modi di produzione sono tenaci nel rifiutare ogni cambiamento, è pur vero che le forze di opposizione non sanno indicare alternative che risolvano i problemi dello sviluppo. Contrastando programmaticamente e con un disegno coerente l’ingiustizia sociale e climatica dai territori in cui ciascuno vive, ci si potrebbe contrapporre al “mainstream”, che sembra accettare ogni prospettiva che rientri nella massimizzazione dei profitti aziendali, nella depredazione della natura e nello sfruttamento del lavoro. Se non c’è ribellione allo “status quo”, si condannano le nuove generazioni ad un futuro non desiderabile.
Galli rileva una continuità col passato che non sembra incontrare ostacoli, anche perché, se i rapporti e i modi di produzione sono tenaci nel rifiutare ogni cambiamento, è pur vero che le forze di opposizione non sanno indicare alternative che risolvano i problemi dello sviluppo. Contrastando programmaticamente e con un disegno coerente l’ingiustizia sociale e climatica dai territori in cui ciascuno vive, ci si potrebbe contrapporre al “mainstream”, che sembra accettare ogni prospettiva che rientri nella massimizzazione dei profitti aziendali, nella depredazione della natura e nello sfruttamento del lavoro. Se non c’è ribellione allo “status quo”, si condannano le nuove generazioni ad un futuro non desiderabile.